
Il countryman
Clint Martin al secondo disco cambia leggermente la focale con la quale ha sempre guardato al country classico, come lui stesso precisa: “
’Proven’ was more of a traditional country effort. It had more clean fiddle and twangy telecaster guitars, whereas ‘Last of a Dying Breed’ has a little more of a rock edge to it. It still has instruments like fiddle and steel guitar, but it also has more overdriven guitar tones”.
In
Last of a Dying Breed, non si nega il percorso incamerato con
Proven, nelle dancehalls regno di cuori spezzati e affamati, ma l’intreccio di violini e steel stavolta innestano tutt’altre derive, spigliate e fresche in
I Love Being Me e nella dolcezza elettrica di
In The Doghouse Again, ma sono poche le sortite in un romanticismo ‘agreste’, dove la natura è un mezzo utile per liberarsi e liberare la giusta dose di country e rock. Forse
Last of Dying Breed è stato pensato soprattutto per solleticare una fascia più ampia di ascoltatori,
Storm of Her Memory – in special modo- alla stessa title track (scritta per suo nonno che dopo una battaglia contro il cancro si è spento nel 2001) a
Gone,
The Long Ride fino alla intensa ballatona piano e steel di
My Ship Ran Aground, l’impressione è che
Clint Martin muovendosi con estrema nonchalance nel new country cerchi di negare il mainstream negli standard più consolidati, ma non sempre riuscendoci.
Restano in penombra le influenze al country più pure, nella spigliata
Living Life's Overdues, al classico –alla George Strait- di
Keepin' it Country, al tocco mariachi della piacevole
Red Rio Grande a stretto contatto con i cowboy del South Texas della ghost track. I diversi stili sembrano scivolargli addosso senza riuscire a tradurre efficacemente quella continuità melodica che voleva essere nelle intenzioni di
Clint Martin. Non una bocciatura, ma un passo indietro rispetto a
Proven.
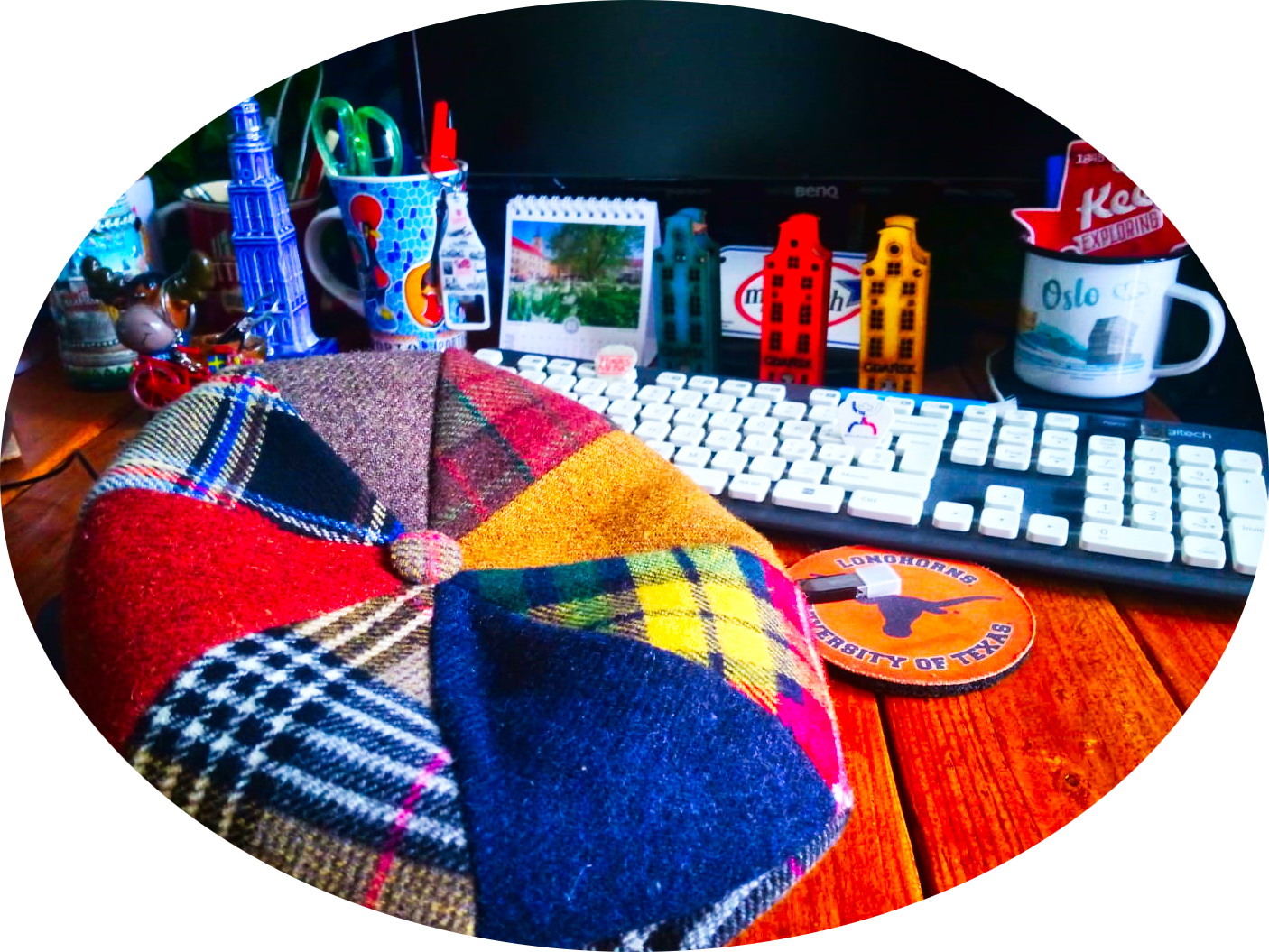 di Pellegrino IACOVELLA
di Pellegrino IACOVELLA